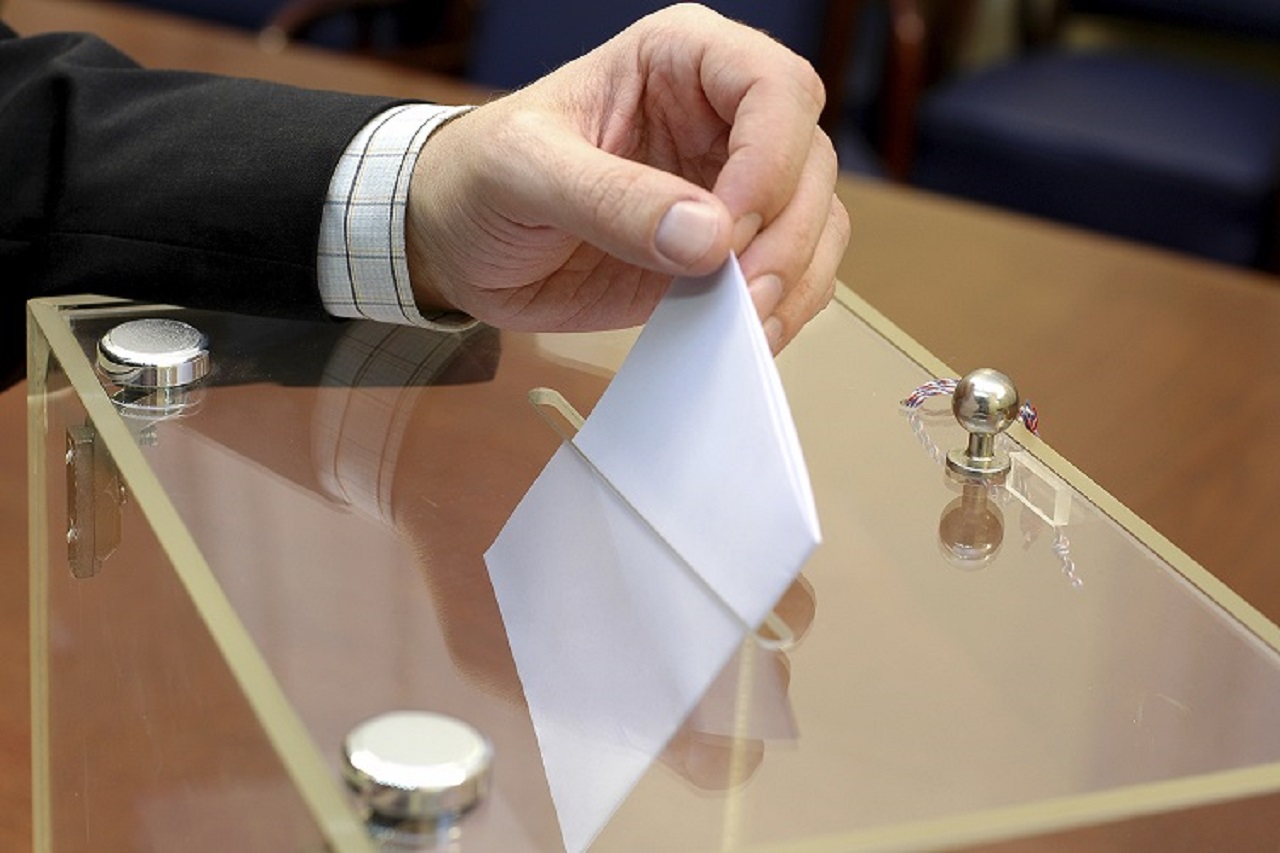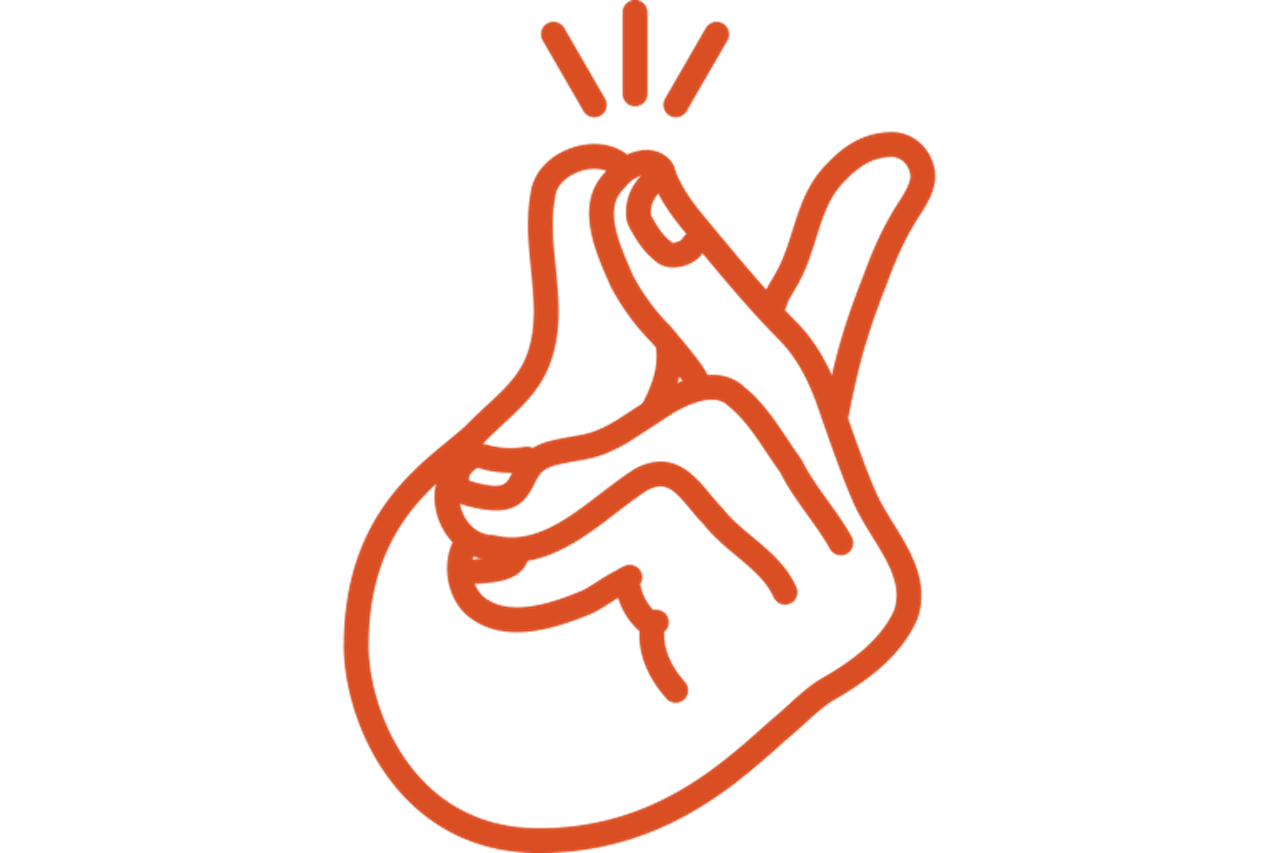Commercio globale 2026: verso un ordine a mosaico
Il commercio internazionale attraversa una fase di trasformazione strutturale che va ben oltre le normali oscillazioni cicliche. Come evidenziato dal «Global Trade Report 2026 – Trade in Transition: How to Prepare for a Patchwork World Order» del Boston Consulting Group (BCG), sta emergendo un vero e proprio “ordine a mosaico”, nel quale geopolitica, sicurezza economica e sovranità nazionale ridisegnano regole, flussi e strategie. Questo articolo riprende i principali spunti del report e li integra con alcune riflessioni sulle implicazioni per le aziende svizzere.

Dalla globalizzazione efficiente alla globalizzazione condizionata
Per circa tre decenni, dalla fine della Guerra Fredda fino alla seconda metà degli anni 2010, il commercio internazionale è stato guidato da una logica di efficienza economica. La progressiva riduzione delle barriere tariffarie, l’espansione delle catene globali del valore e l’integrazione di nuovi Paesi – in particolare la Cina – nel sistema multilaterale hanno sostenuto una forte crescita degli scambi.
Il Global Trade Report 2026 di BCG mostra come questo paradigma si sia progressivamente esaurito. Già prima delle recenti ondate tariffarie erano emersi segnali evidenti di statecraft: ritorno delle politiche industriali, utilizzo del commercio come strumento di pressione geopolitica, crescente centralità delle tecnologie critiche e delle materie prime strategiche. Dal 2022, le misure di politica industriale motivate da obiettivi di sicurezza nazionale ed economica sono aumentate di oltre sei volte, segnando un punto di svolta. Il commercio non è più un fine in sé, ma uno strumento subordinato a obiettivi strategici più ampi.
Il declino del multilateralismo e la geografia policentrica degli scambi
Uno degli elementi centrali messi in luce da BCG è l’indebolimento del multilateralismo. Il WTO continua formalmente a governare una quota rilevante degli scambi globali, ma la sua capacità di aggiornare le regole e risolvere le controversie è fortemente ridotta. In questo vuoto istituzionale, proliferano accordi regionali, plurilaterali e misure unilaterali. Da questa evoluzione emerge un sistema policentrico, definito da BCG come multi-nodal trade patchwork. Non si tratta di blocchi rigidi e impermeabili, bensì di poli che interagiscono in modo selettivo, stabilendo regole diverse a seconda dei partner, dei settori e delle priorità politiche. La geografia degli scambi si sta trasformando profondamente: crescono i flussi Sud-Sud e si rafforzano le relazioni intra-plurilaterali, mentre diminuisce il peso relativo di alcune rotte tradizionali.
Per le imprese, questi cambiamenti implicano la necessità di ripensare modelli logistici, produttivi e commerciali, puntando su maggiore resilienza e sulla capacità di riallocare rapidamente attività e fornitori in risposta a rischi geopolitici o a interruzioni improvvise.
I quattro nodi del nuovo ordine commerciale
| Nodo | Caratteristiche principali | Strategie prevalenti |
| USA | Sicurezza economica, reindustrializzazione | Dazi, reshoring, produzione locale |
| Cina | Integrazione selettiva, autosufficienza tecnologica | Diversificazione partner, filiere interne robuste |
| Plurilateralisti | Regole condivise, accordi profondi | Diversificazione geografica, resilienza, ESG |
| BRICS+ & Global South | Crescita, sovranità, flessibilità | Partnership multiple, adattabilità |
Stati Uniti: sicurezza economica e reindustrializzazione
Nel nuovo ordine commerciale, gli Stati Uniti rappresentano il nodo in cui la sicurezza economica assume la forma più esplicita. Attraverso dazi, incentivi alla produzione domestica, requisiti di contenuto locale e controlli sugli investimenti, Washington punta a rafforzare e ricostruire capacità industriali considerate strategiche per l’economia e la sicurezza nazionale. Le aziende sono incentivate a rilocalizzare segmenti chiave delle catene del valore, a diversificare i fornitori e a privilegiare partner geograficamente e politicamente più vicini, anche a fronte di costi di produzione più elevati. L’obiettivo è creare supply chain più resilienti e meno dipendenti da Paesi considerati rivali o instabili. Per le imprese estere, l’accesso al mercato statunitense resta cruciale, ma è sempre più condizionato dalla capacità di investire e produrre localmente.
Cina: integrazione selettiva e proiezione verso il Sud globale
La Cina segue una traiettoria di integrazione selettiva e duale. Da un lato rafforza il sostegno alle industrie nazionali e accelera il percorso verso l’autosufficienza tecnologica, sviluppando filiere interne sempre più robuste nelle tecnologie critiche; dall’altro, continua a considerare il commercio internazionale un pilastro della crescita. La diversificazione dei partner, in particolare verso il Global South e i Paesi BRICS+, e l’espansione nei settori a maggiore valore aggiunto rispondono sia a esigenze economiche strutturali – come l’assorbimento della sovracapacità industriale – sia a obiettivi geopolitici di lungo periodo, volti a costruire reti di interdipendenza alternative a quelle dominate dalle economie avanzate.
Plurilateralisti: stabilità regolatoria in un mondo instabile
Il nodo dei Plurilateralisti comprende economie che continuano a puntare su regole condivise e accordi commerciali profondi: UE, AELS, Giappone, Canada, Regno Unito e altri partner del CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). In questi Paesi le supply chain sono progettate per garantire resilienza, tracciabilità e conformità a standard elevati, in particolare in materia di ESG e compliance internazionale. Parallelamente cresce la consapevolezza della necessità di ridurre dipendenze eccessive, distribuendo attività produttive e fornitori su più poli, al fine di mitigare i rischi geopolitici e garantire continuità operativa.
BRICS+ e Global South: crescita, sovranità e flessibilità
Le economie BRICS+ (esclusa la Cina) e il più ampio Global South assumono un ruolo sempre più rilevante nel nuovo equilibrio globale. Queste regioni combinano crescita economica, aspirazioni di sovranità industriale e maggiore autonomia strategica. Le supply chain si caratterizzano per elevata flessibilità: le imprese instaurano partnership multiple, modificano fornitori e rotte logistiche in modo dinamico e sfruttano una minore rigidità normativa. Pur non detenendo ancora un ruolo dominante nelle catene del valore più avanzate, questi Paesi sono protagonisti della crescita dei flussi Sud-Sud e delle nuove reti commerciali emergenti.
Implicazioni per le imprese svizzere
Per le imprese svizzere (e non solo), il nuovo ordine commerciale rappresenta una sfida complessa. L’appartenenza al nodo dei Plurilateralisti garantisce stabilità regolatoria e accesso a mercati avanzati, ma non immunizza dagli effetti delle politiche industriali e di sicurezza economica adottate da altri poli. La risposta più efficace consiste – laddove possibile – nell’abbandonare il paradigma della supply chain unica e globale, a favore di architetture multiple, progettate per servire mercati specifici e conformarsi a regimi regolatori differenziati.
Geopolitica e strategie aziendali
Integrare la geopolitica nelle strategie aziendali significa andare oltre il tradizionale risk assessment Paese. È necessario anticipare evoluzioni normative, tensioni tra blocchi economici e le possibili restrizioni su tecnologie e materie prime. Strumenti di scenario planning e competenze interne dedicate consentono di trasformare i segnali geopolitici in decisioni operative e di investimento.
Supply chain: conoscenza e adattabilità
Il passaggio a supply chain multilivello richiede una conoscenza dettagliata di ogni anello della catena del valore. Mappare fornitori, subfornitori e rotte logistiche, valutandone l’esposizione a rischi geopolitici, normativi e climatici, diventa essenziale. L’adattabilità è asset strategico: la capacità di riconfigurare rapidamente la supply chain consente di rispondere a nuove barriere, incentivi o shock esogeni.
Accordi di libero scambio, origine non preferenziale e compliance doganale
La proliferazione di accordi regionali e bilaterali ha generato il cosiddetto spaghetti bowl, una sovrapposizione intricata di regole, tariffe e preferenze che rende il panorama commerciale sempre più complesso. A ciò si affiancano misure quali dazi aggiuntivi, antidumping e restrizioni quantitative, applicate sulla base dell’origine non preferenziale.
- Origine preferenziale: consente di beneficiare di riduzioni o esenzioni daziarie in virtù di accordi di libero scambio.
- Origine non preferenziale: rileva per l’applicazione di dazi, misure antidumping e restrizioni quantitative o altre misure commerciali, sulla base di criteri di lavorazione o trasformazione che possono variare da Paese a Paese.
A questi aspetti si aggiungono i controlli delle esportazioni, che riguardano prodotti a duplice impiego (dual use), sanzioni e restrizioni verso determinati Paesi, soggetti, settori, prodotti e tecnologie critiche. La gestione efficace richiede la conoscenza delle procedure di autorizzazione, sistemi di screening automatizzati e aggiornamento costantemente delle liste di controllo.
Una gestione non corretta può comportare perdita di benefici tariffari, applicazione di dazi ordinari, sanzioni amministrative, blocchi delle merci e rilevanti rischi legali e reputazionali. Solo un approccio integrato alla compliance doganale e all’export control, supportato da personale formato, consente di ridurre i rischi e preservare la competitività.
Governare la complessità come fattore di vantaggio
In un sistema commerciale sempre più frammentato e regolato da molteplici regimi, il vero vantaggio competitivo deriva dalla capacità non solo di assorbire costi aggiuntivi (cost resilience), ma soprattutto di anticipare e governare la complessità, trasformando la frammentazione da rischio a leva strategica.
In questo contesto, automazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale, modelli di business flessibili, competenze avanzate in trade compliance e analisi geopolitica rappresentano leve fondamentali per mantenere margini e posizionamento sui mercati globali.